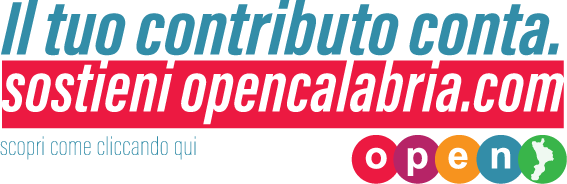La “legge Calderoli” sull’autonomia differenziata, approvata lo scorso giugno, ha sollevato un accesso dibattito e molte contrarietà tanto che, in pochissimo tempo, sono state superate le 500.000 firme necessarie per richiedere il referendum per la sua abrogazione. Ma cosa prevede la legge e quali sono i rischi dell’autonomia differenziata? Davvero la concessione di maggiore autonomia alle Regioni farà aumentare le già ampie disuguaglianze che caratterizzano il nostro Paese?
Il volume “L’Italia differenziata. Autonomia regionale e divari territoriali”, di Vittorio Daniele e Carmelo Petraglia (Rubbettino, 2024), esamina in maniera approfondita, ma senza tecnicismi e pregiudizi ideologici, questi complessi temi. Di seguito ne riportiamo alcuni brani.
Le sirene del regionalismo
L’8 marzo 2001, con i soli voti della maggioranza di centrosinistra, il Parlamento approvava la più importante riforma della Costituzione sin dalla sua entrata in vigore. Una riforma al fotofinish: lo stesso giorno il Presidente della Repubblica Ciampi avrebbe sciolto le Camere. Le modifiche hanno riguardato il Titolo V, che disciplina i rapporti tra Stato, regioni e gli altri enti territoriali; tra le novità, la possibilità per le regioni di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», contenuta in un sintetico comma, il terzo, dell’art. 116.
Dopo ventitré anni, la «legge Calderoli», approvata dal Parlamento il 19 giugno 2024 (legge n. 86), ha applicato quella previsione costituzionale: le regioni potranno ottenere più autonomia in ventitré materie, molte delle quali di particolare rilevanza per la vita di tutti noi: istruzione, sanità, ambiente, grandi infrastrutture. Una nuova ondata di regionalismo destinata a cambiare, per molti aspetti, il nostro paese, a partire dal funzionamento di alcuni importanti servizi pubblici.
Che le regioni richiederanno maggiori spazi di autonomia è cosa pressoché scontata. Tre l’hanno già fatto sottoscrivendo, nel 2018, delle pre-intese con il governo di allora (anche quello di centrosinistra). Si tratta di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, complessivamente rappresentano quasi un terzo della popolazione e ben il 40 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del paese. Per confronto, si consideri che le otto regioni meridionali «pesano», complessivamente, per il 34 per cento della popolazione nazionale, ma solo per il 22 per cento del Pil.
Come il canto delle sirene, l’autonomia esercita un’irresistibile attrazione per i politici regionali. Oltre alle tre regioni citate, prima ancora che si giungesse alla legge Calderoli, anche le altre a statuto ordinario (con l’eccezione di Abruzzo e Molise) hanno manifestato, con atti formali, il loro interesse. Dunque, l’Italia rischia di diventare in pochi anni, per quanto riguarda le competenze regionali, un paese «differenziato».
Un paese disuguale
Storicamente, ci sono (almeno) due Italie: quella del Nord, economicamente più simile alla Germania, e quella del Sud, più simile alla Grecia. Al divario economico se ne accompagnano altri, misurati dagli indicatori sociali e sanitari, che riguardano il funzionamento dei servizi pubblici. Questi divari hanno caratterizzato il percorso di sviluppo del nostro paese: uno stato unitario e, per lungo tempo, caratterizzato da uno spiccato centralismo.
È proprio il centralismo a essere indicato da molti come il problema che trova nell’autonomia regionale la soluzione. Quest’interpretazione, secondo la quale i divari siano il frutto dell’eccesso di centralismo, non convince. Il decentramento di poteri e funzioni attuato negli anni non ha affatto ridotto i divari economici e sociali tra le regioni. Anzi, come nel caso della sanità, i divari rimangono molto ampi.
I divari economici dipendono dalla politica ma anche, e soprattutto, dal mercato. Non così quelli nei servizi pubblici. In ultima analisi, il numero di scuole, di ospedali, di strade o di acquedotti presenti in un territorio dipende da scelte politiche, non dal mercato. Ed è su questi divari che dovrebbe concentrarsi la nostra attenzione perché esprimono realmente la qualità e l’efficacia dell’azione politica nella creazione di condizioni di uguaglianza tra i cittadini.
C’è un legame, dunque, tra divari territoriali e autonomia regionale? Dipendono, i divari economici e nei servizi pubblici, dall’assetto territoriale dello Stato, dalla ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo? Come abbiamo visto, non c’è una risposta univoca a queste domande.
Se si guarda ad altri paesi, non si osserva una stretta relazione tra disuguaglianza nei redditi tra cittadini o tra territori e grado di decentramento. L’Italia è, però, un caso particolare. Lo è perché le regioni in ritardo di sviluppo costituiscono una parte molto ampia del territorio nazionale e i divari interni sono profondi. E ciò ha notevoli implicazioni.
Con l’autonomia differenziata, il sistema di finanziamento delle nuove funzioni devolute alle regioni, basato sulle compartecipazioni al gettito dei tributi statali raccolto sul territorio, farà sì che quelle più ricche abbiano più risorse disponibili. Potranno, così, offrire più servizi ai propri cittadini e, eventualmente, offrire stipendi più alti a insegnanti, medici e personale pubblico.
In un paese come il nostro, è prevedibile che le differenze nei servizi e nei salari dei lavoratori pubblici e privati alimenteranno le già consistenti migrazioni dal Sud verso il Nord. Ciò, in un meccanismo cumulativo, fornisce risorse allo sviluppo delle aree più ricche, mentre contribuisce all’arretramento di quelle più povere. La richiesta di maggiore autonomia, che ha alla sua origine il problema delle disuguaglianze regionali, comporta, come esito, che quel problema si aggravi.
A causa delle differenze nei livelli di sviluppo, le regioni hanno diverse capacità fiscali per finanziare i servizi. A ciò si sarebbe potuto porre rimedio da un ventennio, fissando i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e assicurando, attraverso trasferimenti statali (cioè da altre regioni), i fondi per garantirli. Questo è, ad oggi, uno degli aspetti più critici dell’autonomia differenziata.
Ripensare il ruolo dello Stato
Forte è, dunque, il rischio che i divari aumentino e che i «diritti di cittadinanza» dipendano, più di quanto già accada, dal livello di sviluppo delle regioni. È, perciò, necessario che lo Stato assuma un ruolo incisivo in favore dell’equità e del riequilibrio territoriale. Per evitare che il regionalismo differenziato accresca le disuguaglianze è, cioè, necessario che si completi il processo di federalismo fiscale, dando piena attuazione ai princìpi costituzionali della perequazione territoriale, della coesione e della solidarietà nazionale. Paradossalmente, ciò richiederà un consistente trasferimento di redditi dalle regioni più ricche verso il Mezzogiorno. È un paradosso se si pensa che, con l’aumento dell’autonomia, si dovrebbe realizzare l’obiettivo che, per anni, ha costituito il cavallo di battaglia della Lega Nord, ovvero quello di trattenere nelle regioni settentrionali larga parte del gettito fiscale prodotto.
In ultima analisi – come dimostrano le esperienze di altri paesi, a cominciare dalla Germania – l’equità nei servizi pubblici dipende, in larga parte, dall’efficacia dei meccanismi di perequazione tra regioni. È difficile, però, che lo Stato possa destinare più risorse a tale scopo, considerato che l’attribuzione di maggiore autonomia alle regioni più ricche si rifletterà, inevitabilmente, sulle entrate statali e che, con ogni probabilità, la crescita economica italiana continuerà a essere lenta anche in futuro, come, del resto, è da oltre un ventennio.
La coperta potrebbe, cioè, non essere in grado di coprire tutti. C’è il rischio che il regionalismo differenziato riduca le entrate disponibili per lo Stato e che, dunque, venga compressa la sua funzione di riequilibrio territoriale. Non è un rischio ipotetico. Del resto, è quanto avviene da tempo, considerato il declino degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno.
Risorse ma anche capacità
L’impatto dell’autonomia sulle disuguaglianze dipenderà, però, non solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità del ceto politico e delle amministrazioni locali di garantire i servizi. Per diverse ragioni, anche oggettive, il funzionamento delle amministrazioni, misurato da indicatori di efficienza e, soprattutto, di risultato, differisce tra Nord e Sud. Si consideri, però, che non è la stessa cosa governare un territorio con più risorse e meno problemi socioeconomici strutturali e uno che, invece, quei problemi li presenta in forma acuta. Un conto è amministrare Milano o Treviso, un altro Napoli o Palermo. È, tuttavia, necessario prevedere meccanismi realmente efficaci di valutazione della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche, per evitare ingiustificabili disparità di trattamento tra i cittadini delle diverse aree del paese.
Il settore sanitario è quello in cui le regioni godono del maggior grado di autonomia ed è anche quello in cui maggiori sono i divari tra Nord e Sud. Divari misurati da indicatori economici e, cosa molto più importante, da quelli che riguardano le condizioni di salute e gli standard delle cure. E che i divari siano significativi lo dimostrano i cittadini meridionali votando, come si dice, «con i piedi», cioè rivolgendosi ad altre regioni per le cure. Il progressivo smantellamento della sanità pubblica, le inefficienze e i lunghi tempi di attesa fanno sì che, specie nelle regioni dove questi problemi sono più acuti, quelle del Sud, i cittadini saranno costretti a pagare sempre più di tasca propria per poter accedere in tempi ragionevoli alle cure; l’alternativa rimane, quando possibile, quella di «emigrare» per potersi curare.
Ecco, ogni discussione sull’autonomia delle regioni dovrebbe partire da una riflessione su ciò che è accaduto e accade nella sanità, sulle cause delle differenze regionali negli standard delle cure, dalle motivazioni dell’elevata migrazione sanitaria delle regioni meridionali, dalla domanda sul perché ciò che funziona al Nord non funziona allo stesso modo al Sud.