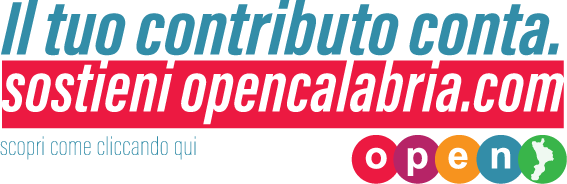Un fantasma si aggira per l’Europa: la paura che nel referendum di giovedì 23 giugno la maggioranza degli inglesi decida per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. La vittoria dei sì al referendum inglese preoccupa non tanto per i suoi effetti immediati, quando per il rischio che l’uscita del Regno Unito possa innescare una reazione a catena che porti alla disintegrazione dell’Unione. Non si può però escludere che lo shock causato da una eventuale Brexit possa innescare un ripensamento radicale delle modalità operative dell’Unione Europea con effetti positivi, in particolare per la Calabria, per le altre regioni del Mezzogiorno, e anche per le regioni del Nord dell’Italia.
Ciò che negli ultimi tempi ha innescato forti contrasti fra i paesi dell’Unione europea é stata la gestione del flusso dei rifugiati provenienti dai paesi dell’Africa e del Medio Oriente. In realtà la crisi ha motivazioni molto più profonde, che riguardano soprattutto il contrasto fra gli obiettivi formulati periodicamente nei vertici europei e i risultati effettivamente conseguiti. Secondo l’obiettivo formulato nel 2000 a Lisbona dal vertice dei capi di Stato e di Governo, l’Unione europea sarebbe dovuta diventare “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Un contributo fondamentale al raggiungimento di quest’obiettivo doveva venire dall’adozione di una moneta comune, partita con 11 paesi nel 1999, e allargata negli anni successivi fino a coinvolgere 19 dei 28 paesi dell’Unione europea, più altri due paesi, Danimarca e Romania, che, pur mantenendo la propria moneta, hanno stabilito un tasso di cambio fisso con l’euro.
In realtà, fra il 1998 e il 2016, il tasso di crescita della produzione e del reddito dei paesi dell’euro-zona è stato deludente, sia in rapporto alla crescita realizzata in passato dagli stessi paesi, sia rispetto alle altri grandi aree del mondo. Fra il 1998 e il 2016 il tasso medio di crescita della produttività del lavoro nei paesi dell’euro-zona é stato di circa lo 0,5% all’anno, mentre era stato dell’1,7% all’anno nel decennio fra il 1985 e il 1995. La deludente performance della produttività nell’euro-zona appare ancora più evidente se si confronta con gli Stati Uniti; nonostante la crisi finanziaria scoppiata nel 2007, fra il 1998 e il 2016 negli USA la produttività del lavoro é cresciuta in media di circa l’1,5% all’anno, un tasso di crescita significativamente maggiore che fra il 1985 e il 1995 (1,1% all’anno). Gli anni duemila hanno visto quindi allargarsi di nuovo la forbice in termini di produttività, e quindi di reddito per abitante, fra gli Stati Uniti e il nucleo centrale dell’Unione europea, che si era ristretta gradualmente nei 50 anni precedenti.
Al fallimento in termini di produttività per occupato si è aggiunto il fallimento in termini di occupazione, sia per quel che riguarda la media dell’eurozona, sia, ancor di più, per quel che riguarda gli squilibri territoriali. Secondo le stime dell’Economist, ad aprile-maggio 2016, il tasso medio di disoccupazione era in media dell’11,1% nei paesi dell’eurozona, del 5,5% negli Stati Uniti e nel Regno Unito, del 4,1% in Cina, del 3,3% in Giappone. Oltre ad essere in media molto alto, il tasso di disoccupazione dell’eurozona evidenzia anche squilibri territoriali molto forti; si passa da valori del 4,7% in Austria e del 6,4% in Germania, al 12,4% dell’Italia, al 22,7%, della Spagna, al 25,6% della Grecia. Addirittura drammatico appare il fallimento delle politiche di “coesione” dell’Unione europea in termini di squilibri territoriali dal punto di vista del tasso di disoccupazione giovanile. Secondo i più recenti dati Eurostat, il tasso di disoccupazione per le persone di età compresa fra 15 e 24 anni varia dal 3,4% dell’Oberbayern (Germania) al 65,1% della Calabria.
Gli attuali squilibri fra paesi dal punto di vista del tasso di disoccupazione derivano essenzialmente dalla pessima gestione dell’Unione monetaria europea, focalizzata pressoché esclusivamente sui saldi complessivi di finanza pubblica, senza neppure distinguere fra spese per consumi e spese per investimenti pubblici, trascurando per molto tempo la divergente dinamica dei prezzi dei beni prodotti nei diversi paesi. Fra il 1998 e il 2008 il prezzo medio dei beni prodotti all’interno (deflatore implicito del PIL), aumentò gradualmente di più che in Germania di circa il 30% in Spagna e in Grecia, e di circa il 18% in Italia. Le implicazioni negative per l’Unione monetaria di questa divergente dinamica dei prezzi interni era stata evidenziata fin dal febbraio 2005 in un articolo dell’Economist[1], nessun significativo intervento correttivo fu tuttavia realizzato per impulso della Commissione europea. Furono i mercati finanziari che, a partire del 2008, si resero conto del gravissimo rischio che ciò comportava per la stabilità dell’eurozona, e soltanto da allora furono imposte misure fortemente deflazionistiche in Grecia, Spagna e Italia, che, al costo di forti aumenti della disoccupazione, hanno ridotto in questi paesi la dinamica del prezzo del lavoro in modo da ristabilire l’equilibrio competitivo da cui ci si era sempre più allontanati nel decennio precedente. Molto modesto fu invece il contributo al riequilibrio competitivo da misure espansive in Germania.
Forti squilibri territoriali dal punto di vista delle opportunità di lavoro esistono non soltanto fra diversi paesi dell’Unione europea ma all’interno di alcuni paesi. Per l’Italia, in particolare, secondo le stime contenute nell’ultima Relazione annuale della Banca d’Italia, nel 2015 il tasso di disoccupazione medio é stato dell’8,1% nelle regioni del Nord (con un minimo di circa il 5% in Trentino-Alto Adige), del 10,6% nelle regioni del Centro, e del 19,4% nelle regioni del Mezzogiorno (con un massimo di circa il 23% in Calabria). Ancora più forti appaiono gli squilibri regionali italiani in termini di tassi di occupazione: nel 2015 il tasso di occupazione è stato del 64,8% nelle regioni del Nord dell’Italia (con un massimo di circa il 69% in Trentino-Alto Adige), del 61,4% nelle regioni del Centro, del 42,5% nel Mezzogiorno, con un minimo di circa il 39% in Calabria, Campania e Sicilia. Il tasso di occupazione registrato in Calabria, Campania e Sicilia nel 2015 è stato pari a poco più della metà del tasso di occupazione del 75% posto come obiettivo dalla Strategia Europa 2020!
Un tasso di occupazione così basso in Calabria e nelle altre regioni del Sud dell’Italia ha implicazioni fortemente negative non soltanto per il Mezzogiorno ma anche per le regioni del Nord dell’Italia, che devono destinare una parte significativa delle imposte in esse riscosse per finanziare una parte consistente della spesa pubblica effettuata nelle regioni del Mezzogiorno (“residuo fiscale”).
La causa fondamentale del bassissimo tasso di occupazione in Calabria e nelle altre regioni del Mezzogiorno é una carenza di competitività che fa sì che gran parte della domanda interna di beni a mercato internazionale del Mezzogiorno attivi occupazione al di fuori del Mezzogiorno, mentre è molto bassa l’occupazione attivata nel Mezzogiorno dalla domanda di beni che ha origine al di fuori del Mezzogiorno. Ciò ha una ulteriore implicazione negativa per il Nord dell’Italia, perchè l’eccesso di importazioni del Mezzogiorno deve essere compensato da un avanzo commerciale delle regioni del Nord dell’Italia, che richiede in quelle regioni salari di equilibrio più bassi[2].
Dal punto di vista economico, la cura classica dello squilibrio competitivo fra Nord e Sud dell’Italia sarebbe una differenza nelle retribuzioni per addetto in tutti i settori produttivi, compensative della differenza di produttività nelle produzioni a localizzazione non vincolata (beni a mercato internazionale). L’esperienza storica ha tuttavia evidenziato chiaramente la non attuabilità politica di una soluzione di questo tipo, soprattutto perchè essa dovrebbe riguardare anche le amministrazioni pubbliche. Una soluzione alternativa, potrebbe essere rappresentata da sgravi fiscali per le attività produttive a localizzazione non vincolata localizzate nel Mezzogiorno, che avrebbero effetti analoghi a differenziazioni retributive generalizzate a tutti i settori produttivi. A partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo c’é stata però una opposizione rigida da parte della Commissione europea a significative e durature misure di “fiscalità di vantaggio” per il Mezzogiorno, senza che si possa comprendere la giustificazione economica di tale contrarietà[3].
Questo atteggiamento della Commissione europea, in una situazione di impraticabilità politica di significative differenziazioni retributive in tutti i settori, comprese le amministrazioni pubbliche, condanna il Mezzogiorno a una situazione di forte carenza di opportunità di lavoro, con effetti negativi anche di natura politica e sociale, e il Nord dell’Italia a politiche fiscali e salariali fortemente restrittive, per ottenere avanzi del bilancio pubblico e degli scambi con l’estero compensativi dei fortissimi disavanzi del Mezzogiorno.
Se lo shock di una “Brexit” potesse stimolare un ripensamento radicale, anche in questo campo, delle politiche dell’Unione europea, le sue conseguenze, almeno per l’Italia, potrebbero forse essere positive.
[1] “the euro area may have a single currency, but it still has many different real exchange rates”, the Economist, 17/02/ 2005.
[2] Il “double burden” dei trasferimenti internazionali o interregionali fu evidenziato da Mill nel caso dei trasferimenti dall’Irlanda verso l’Inghilterra nel diciannovesimo secolo, e da Keynes nel caso delle riparazioni di guerra imposte alla Germania dopo la prima guerra mondiale.
[3] Dubbi sulla logica economica della posizione della Commissione europea sono stati espressi, fra gli altri, da Gianpaolo Galli, Tito Boeri, Francesco Giavazzi, Riccardo Faini. In particolare, Giavazzi e Faini, in un articolo su “Lavoce.info” del 2 agosto 2004, commentando il DPEF presentato dall’allora Ministro dell’Economia Domenico Siniscalco scrivevano: “in materia fiscale coraggioso è invece l’impegno (p. 30) ad aprire le ostilità con Bruxelles sulla differenziazione regionale delle aliquote sui profitti. La Commissione e la Corte di Giustizia fanno risalire il divieto alla differenziazione regionale delle aliquote a una interpretazione dell’articolo 92.1 del trattato. Esso tuttavia esclude “aiuti di Stato che distorcano la concorrenza”, non la differenziazione regionale delle aliquote”.
Lo stesso ministro “leghista” del Governo Berlusconi Giancarlo Pagliarini, in un articolo su “La Padania” del 16 aprile 2000, scrisse di essere stato costretto dalla rigidità della Commissione europea ad accettare nel 1994 l’accordo con il commissario Van Miert che obbligava l’Italia ad eliminare in un triennio gli sgravi fiscali per le imprese manifatturiere del Mezzogiorno.